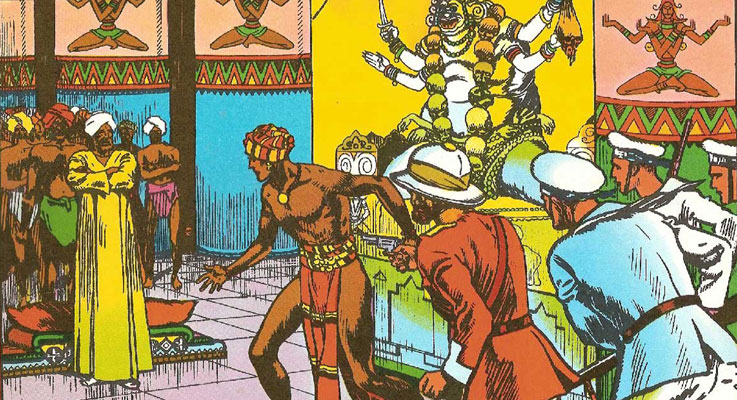
[Illustrazione di Gennaro D’Amato per “I misteri della jungla nera” di Emilio Salgari, 1887]
Uno stanco ritornello recita che i ragazzi italiani non leggono da due generazioni. Il dato è reale e si ama farlo risalire all’avvento dei social network che avrebbero distolto l’attenzione dalla pagina scritta. Ma, siamo così certi che sia l’unica ragione?
Cercherò in questo articolo della domenica di approfondire il tema e di valutarne le conseguenze in termini di mancato sviluppo dell’immaginazione e di scarsa attitudine al cambiamento di cui paghiamo il prezzo.
![]()
Nell’articolo pubblicato venerdì scorso ho posto a me stesso ed ai lettori de Lo Spessore la seguente domanda:
“E se, ormai dimenticati gli anni della giovane Repubblica e confinati nella vergogna quelli più recenti, fosse una democrazia senza emozioni a lasciare lo spazio al potere delle emozioni, attraendo molti giovani e meno giovani che, pur insieme a tanti altri che le indirizzano al volontariato e alla solidarietà, credono di trovarle in militanze che la storia ha sepolto, in talune tifoserie che ne hanno alimentato il ricordo attraverso gesti, linguaggi e slogan o in antiche religioni dell’assoluto dove all’uomo è comandato di temere l’ira della divinità?”
La risposta, complessa e articolata, richiederebbe – più che un articolo – un poderoso saggio dedicato alla responsabilità di famiglie ed educatori ad ogni livello nel non motivare abbastanza i giovani alla lettura, ma qui è sufficiente fare il punto sul ruolo degli scrittori italiani.
Fino ad un certo momento, i poeti ed i narratori hanno “isolato” singoli individui o piccoli gruppi di essi, cercando di indagarne le vite – umane, umanissime – nell’incontro con i grandi eventi che siamo soliti chiamare storici. Ed ecco, di colpo, date, battaglie e armistizi, luoghi e personaggi ci hanno raggiunto direttamente perché attraverso essi il narratore ha fatto comprendere le radici e gli effetti degli eventi o, paradossalmente, il contrario.
Abbiamo notizie dell’Armata napoleonica in Russia più da Tolstoy che da Bogdanovic, della Prima Guerra Mondiale più da Bedeschi o da Hemingway piuttosto che Gilbert, della battaglia di Waterloo da Hugo piuttosto che da Taine o da Courrier, della Guerra in Libano più da Oriana Fallaci (Inshallah) che da Fisk, sulla Shoà più da Levi, o dallo Spielberg di Schindler’s List, che da Fest e potremmo continuare con l’elenco infinito degli eventi storici e con l’altrettanto inevitabile contrapposizione tra storici di professione e narratori.
Allo stesso modo si è appreso di più sulla realtà contemporanea leggendo scrittori di narrativa avventurosa quali Wilbur Smith, Clive Cussler o Tom Clancy, Ken Follet che, a differenza di Le Carrè o di Ludlum più attenti al genere spy story, favoriti dalla diffusione planetaria della lingua inglese, hanno saputo conquistare molti lettori mescolando storia e fantasia e, soprattutto, generando emozioni.
Non starò certo qui a spiegare quale sia il ruolo di esse nello sviluppo umano, basterà soltanto ricordare che l’etimologia della parola “emozione” è da ricondursi al latino emovère (ex = fuori + movere = muovere) letteralmente portare fuori, smuovere, in senso più lato, scuotere, agitare; per cui l’emozione è un’agitazione, uno scuotimento, una vibrazione dell’animo. Ancora più affascinante è l’origine greca del termine: il prefisso “emo” deriva dal greco, emo (sangue), ascrivendo all’emozione il significato di una risposta corporea che proviene dal sangue; dunque, la psiche agita il sangue in base a come l’uomo interpreta gli eventi che vive direttamente e che gli vengono raccontati da un paesaggio, un dipinto, una statua, un film, un libro.
Nella “Critica del Giudizio” Immanuel Kant sostiene che la sintesi tra percezione ed emozione costituisca il motivo determinante di quella distinzione del sublime dal bello, che non sussisteva nella concezione classica e che qui invece assume importanza capitale
Mentre il bello, infatti, risulta dall’accordo tra la facoltà rappresentativa e i concetti dell’intelletto, nel sublime si ha invece una sorta di sintesi tra quella facoltà e le idee delle ragione: se il bello è perciò, in base all’applicabilità dei concetti dell’intelletto all’intuizione della natura, rappresentazione limitata e armonica, il sublime risulta invece dall’effetto che una rappresentazione della natura produce in quanto, col suo senso di grandezza o potenza smisurata, richiama per reazione l’idea di ciò che è veramente infinito, cioè il regno noumenico della ragione, che è quello stesso della libertà morale.
S’intende così la definizione kantiana secondo cui “il sublime è un oggetto della natura, la cui rappresentazione determina il sentimento a concepire l’irraggiungibilità dei limiti della natura come rappresentazione di idee della ragione”. Il sublime si distingue poi, per Kant, in “sublime matematico” e in “sublime dinamico” a seconda che quella illimitatezza naturale si manifesta nel senso dell’estensione (p. es., nell’immensità dei cieli) o in quello della potenza (p. es., nell’oceano in tempesta). Alla concezione kantiana fanno riferimento, pur nelle variazioni particolari, tutte le altre teorie del sublime propugnate dall’estetica tedesca dell’Ottocento; mentre l’estetica contemporanea, e in particolare quella italiana, ha eliminato il problema stesso del sublime, risolvendone, da un lato, il concetto in quello generale del valore artistico e, dall’altro, dimostrandone il carattere extraestetico.
Per Schiller nel trattato Del Sublime esistono due “geni” che la natura ci ha dato come compagni della nostra vita. Il sentimento del bello è socievole e benevolo e con il suo lieto agire sembra abbreviare il nostro viaggio, ma è legato ai sensi ed è valido solo tra uomini. Il sentimento del Sublime invece è grave e taciturno, e ci porta al di là dell’abisso vertiginoso ed è sintesi tra un senso di pena che si manifesta come brivido e un senso di letizia.
Tra i molti artisti che, a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento, hanno interpretato più o meno consapevolmente l’estetica del sublime, merita una menzione particolare il pittore inglese William Turner, i cui uragani, le cui bufere di neve e le cui battaglie marine rappresentano l’incarnazione pittorica di questa idea. Suo complementare è il tedesco Caspar David Friedrich, con tele in cui l’uomo è raffigurato minuscolo di fronte alla grandezza della natura, mentre la sua controparte inglese è John Constable, con una differente interpretazione del sublime applicata al quotidiano.
Alla fine del secolo scorso William James, uno psicologo irlandese naturalizzato negli USA, fu il primo a definire l’emozione in termini operativi come “il sentire i cambiamenti neurovegetativi che hanno luogo a livello viscerale a seguito dello stimolo elicitante”. Secondo l’autore, infatti, l’evento emotigeno determinerebbe una serie di reazioni viscerali e neurovegetative che sono avvertite dal soggetto; la percezione di queste modificazioni fisiologiche sarebbe alla base dell’esperienza emotiva.
Lo stesso James afferma in “What is Emotion” del 1884: “Il senso comune dice che ci accade qualcosa di brutto, siamo dispiaciuti e singhiozziamo (…) La mia ipotesi (…) è che ci sentiamo dispiaciuti perché piangiamo, arrabbiati perché ci accaloriamo, impauriti perché tremiamo.”
In questo modo, viene capovolta l’impostazione della psicologia ingenua secondo la quale, ovviamente, noi piangiamo perché siamo tristi, e non viceversa. Una posizione teorica di questo tipo implica che diverse emozioni abbiano correlati fisiologici ben distinti e James si basava appunto sulla constatazione che le principali emozioni (rabbia, paura, tristezza, felicità, sorpresa, disgusto) abbiano espressioni somatiche diverse.
Riguardo a tale posizione teorica sono state avanzate numerose critiche, dettate dalla scarsa presenza di dati empirici. In particolare, il fisiologo statunitense Walter Bradford Cannon negli anni venti del ‘900 si contrappose alla teoria di James sostenendo, in base a dati sperimentali, che: “ anche se viene interrotta la comunicazione tra visceri e sistema nervoso centrale, il comportamento emotivo non subisce alterazioni; certe modificazioni viscerali sono le stesse per molte emozioni e anche per stati non emozionali; i visceri sono strutture scarsamente innervate e le loro modificazioni hanno latenze troppo lunghe per poter causare risposte rapide richieste da un’emozione.”
Sulla base di questi dati, Cannon elaborò una teoria centrale delle emozioni, secondo la quale i centri di attivazione, di regolazione e di controllo dei processi emotivi non si trovano in sedi periferiche come i visceri, ma sono localizzati centralmente nella regione talamica. L’intero processo può essere così schematizzato: un evento esterno stimola i recettori che mandano impulsi alla corteccia che, a sua volta, stimola i processi talamici che agiscono nell’area corrispondente a una particolare emozione.
Ricerche successive hanno dimostrato che i processi del sistema nervoso centrale (SNC) sono molto più articolati di come supposto in origine da Cannon, ma un concetto nella sua teoria rimane ancora oggi immutato; l’idea che alla base di tutte le emozioni ci sia una forte attivazione indifferenziata, definibile come “reazione d’emergenza”, suscitata da fame, dolore, paura, rabbia, ecc. Su questo studio si basano le successive teorie dell’attivazione e della motivazione.
Credo che basti per poter affermare come ogni attività umana che non riesca a suscitare un’emozione non ottiene risultati apprezzabili in alcun campo e in particolare in quello educativo, vocato ad incidere sulla crescita del singolo e sui comportamenti collettivi ed a sviluppare quell’intelligenza emotiva a cui lo psicologo Daniel Goleman ha dedicato l’intera propria ricerca, con risultati molto apprezzati anche nel mondo del management e nella fase antropologica del passaggio dal lavoro manuale, progressivamente sostituito dall’impiego delle macchine, a quello intellettuale, richiesto oggi ad ogni livello.
Con Intelligenza Emotiva ci si riferisce a un costrutto psicologico che si sviluppa negli anni ’90 del secolo scorso e definisce la capacità di usare le emozioni con intelligenza, identificandole, comprendendole, gestendole per riuscire ad affrontare meglio la vita.
Le emozioni sono dotate di una forza dirompente che può ostacolarci nel raggiungimento dei nostri obiettivi, per esempio paralizzando la nostra capacità di agire o di decidere lucidamente. Se adeguatamente gestite, possono però regalarci una marcia in più aiutandoci a comunicare efficacemente, a saperci auto-motivare, a reagire meglio agli stimoli provenienti dall’ambiente.
E, allora, cosa e chi educa alle emozioni? Un articolo più o meno dotto – magari un po’ noioso, ma utile, ad avviso di chi scrive, per capire ciò di cui state leggendo, come questo – o una pagina che fa vivere al lettore grandi orizzonti, sfide potenti, difficoltà che ad altri possono apparire insormontabili, vicende che dall’antichità ad oggi altro non sono altro che “viaggi di formazione”?
In Italia, il genere avventuroso per molto tempo è stato confinato nel mondo degli adolescenti anche quando i testi originali erano di grande complessità e, da quando essi non leggono più né quello né altro, sono destinati a diventare adulti che difficilmente saranno in grado di “mobilitarsi” in quanto spinti da emozioni forti. Né il potere dell’immaginazione derivante dalla lettura potrà mai essere superato dall’immagine televisiva, cinematografica o digitale, fruizioni passive che non stimolano la produzione di immagini mentali. Le stesse che, invece, ciascuno di noi, in modo assolutamente personale ed unico, configura allo stesso modo della prima volta in cui lesse un romanzo, ancor più se d’avventura, da giovane.
Delle prime pagine de “L’isola del tesoro” o di “Moby Dick” come de “I Promessi Sposi” o de “Il Gattopardo” piuttosto che de “I tre moschettieri” o de “Il giro del mondo in 80 giorni” esistono immagini createsi nel pensiero in numero coincidente con quello di chi ha letto quei capolavori, a differenza di quanti ne hanno fruito le versioni cinematografiche e per i quali esse saranno le stesse per tutti, con buona pace dell’immaginazione.
Corollario di questa affermazione, ardita ma solo fino ad un certo punto, è la constatazione della presa che movimenti politici di diversa e non sempre commendevole natura, ottengono evocando mondi e modi di essere in cui le emozioni, orientate secondo il fine dei promotori, risvegliano quel bisogno di voler appartenere ad un mondo che essi indicano e su cui, secondo Robert Dilts, si fonda in larga parte la costruzione di una leadership. Un “potere di convocazione” direbbe il compianto Piero Trupia, a cui è difficile non aderire e che funzione sempre, a prescindere dalle finalità di chi lo pone in essere.
Un potere che, ad avviso di chi scrive, non sembra risiedere nell’infinita produzione di testi narrativi nostrani popolati da commissari e brigadieri, da sostituiti procuratori e graduati, da coppie in crisi o da protagonisti più della cronaca che della letteratura, il cui unico fine sembra solo quello di approdare al piccolo schermo mentre si indeboliscono la fiducia nella capacità, tutta umana, di misurarsi con le grandi difficoltà che la vita e l’ambiente pongono oggi più di ieri. Piccole storie di quotidianità che, in mille “sfumature di grigio”, sconfinano in un intimismo su cui difficilmente un produttore di Hollywood sarebbe disposto ad investire.
Ecco allora spiegata l’attesa spasmodica del prossimo film della saga di Indiana Jones, il quinto della serie, in cui, come ieri per Sean Connery e l’epopea di James Bond, si richiamano in servizio attori di culto come Harrison Ford che, in mancanza di altro e di meglio, scatenano quelle emozioni di cui tanto ciascuno ha bisogno per essere stimolato a realizzarsi, sfidando ciò che lo circonda impedendogli di essere padrone – ed eroe – della propria esistenza.
E, per quanto grande sia la mia stima verso giganti del cinema italiano come Tony Servillo, sinceramente non lo vedo quale interprete di storie in grado di cambiare la visione del mondo a dei giovani che, indubbiamente, preferiscono ancora identificarsi con i vincenti piuttosto che con gli “sfigati” alla cui categoria a quell’età, per definizione, hanno l’orrore di rischiare di appartenere.
Il ritorno della letteratura d’avventura cambierà la società di un Paese che vuole svoltare ma non sa verso dove, come avvenne invece in termini di spinta per generazioni ormai quasi del tutto estinte ? Io credo di sì e spero proprio che settecento anni dopo il racconto più affascinante della storia dell’Umanità – ancora una volta un viaggio, ovviamente – anche quella narrazione che da troppo tempo aspettiamo torni a parlare italiano.
“Le distanze esistono per essere percorse, è chiaro, se non c’è distanza non c’è desiderio, se non c’è desiderio non c’è avventura, se non c’è avventura non c’è un bel niente per cui valga la pena di vivere.” Hegel o Sartre, Hölderlin o Conrad ? Nessuno di loro. “Solo” Lorenzo Cherubini detto Jovannotti, un quasi sessantenne che con il potere immaginifico della musica, ha saputo intercettare il bisogno di sfida e la voglia di avventura di due generazioni di giovani.

